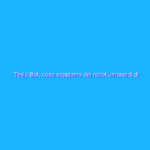Questa umile macchia d’inchiostro riesce a sopravvivere a molti danneggiamenti perché usa la correzione d’errore: della matematica piuttosto complessa, sviluppata nel 1960 da Irving Reed e Gustave Solomon presso un centro di ricerca militare del MIT, in Massachusetts, che include nella mappa di puntini alcuni dati di controllo. Questi dati dicono cosa ci deve essere scritto nei puntini precedenti. Se quei puntini non sono leggibili, per esempio perché sono stati danneggiati, cancellati o coperti, la correzione d’errore permette di ricostruire l’informazione mancante. Questo è molto utile negli ambienti nei quali si usano i codici QR, che sono soggetti a graffi, ammaccamenti, cancellazioni e abrasioni.
Semplificando moltissimo, immaginate che i dati da proteggere siano i numeri 1, 3, 5 e 11: la correzione d’errore aggiunge l’informazione “il totale dei numeri precedenti deve essere 20” e quindi se uno dei numeri risulta illeggibile è possibile dedurlo. Questo è solo un esempio grossolano: la matematica della correzione d’errore nei codici QR è molto, molto più complessa, ma il concetto di base è lo stesso.
Resistenza ai danni e matematica militare: niente male, per un semplice quadratino stampato, vero?
Questa correzione d’errore ha anche una conseguenza estetica poco conosciuta: siccome i dati registrati nei codici QR sono appunto ricostruibili anche se il codice è parzialmente danneggiato, è possibile produrre dei “danneggiamenti” artistici: per esempio, si può inserire un logo al centro o in un angolo del codice per personalizzarlo o abbellirlo, oppure si possono cambiare alcuni colori o inserire dei simboli all’interno dei quadratini di riferimento, e il codice risulterà leggibile lo stesso.
Il prezzo di questa miglioria estetica è una minore resistenza dei codici QR “artistici” ai danneggiamenti, ma se l’ambiente in cui vengono usati non è troppo ostile è un compromesso accettabile.
I codici QR possono inoltre contenere moltissime informazioni: fino a 7089 numeri oppure 4296 caratteri alfanumerici o 1817 simboli Kanji o Kana. Per fare un esempio concreto, due soli codici QR conterrebbero tutte le parole di questo podcast. Un bel passo avanti, rispetto alla ventina di caratteri dei vecchi codici a barre.
Robusto, capiente, compatto, economico e facile da stampare ovunque e da leggere con gli smartphone: non sarà un capolavoro di estetica, ma il codice QR fa bene il proprio lavoro e inquina molto meno delle soluzioni alternative, come per esempio i microchip usa e getta. Soprattutto, ci dà un’occasione per scoprire quanta complessità matematica e informatica c’è dietro gli oggetti apparentemente più semplici che usiamo tutti i giorni.
Fonti aggiuntive: Gizmodo, Forbes.